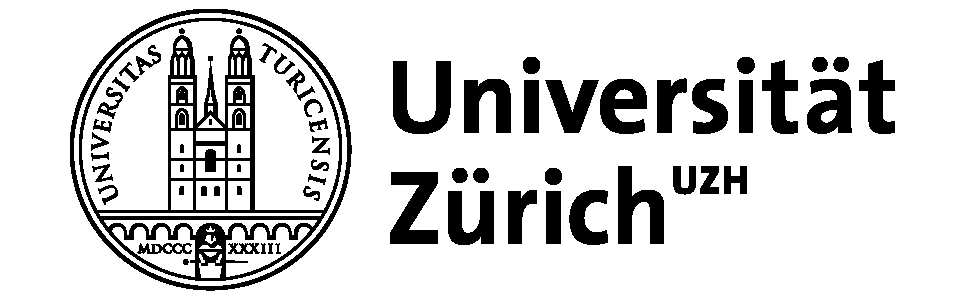Nemico oppure alleato? La nuova identità italiana e tedesca durante la Grande Guerra nelle memorie dei corrispondenti dalla Germania
Pia Carmela Lombardi
Università degli Studi di Trento / Universität Augsburg
Abstract: This paper examines the memoirs written by Italian correspondents abroad during the Great War years. These written productions represent an important source for analysing the changing perception of Italian and German identity during the World War. The ego-documents reflect and narrate, without restriction, the moods, and events of the journalists at a historical moment when Italian identity began to be perceived as an enemy to be fought or an ally to be conquered. When the First World War broke out in July 1914, many Italian correspondents decided to remain in the various foreign countries where they had been living for a few years to continue reporting the news of the ongoing war events. If in their articles one can observe a certain detachment in the narration of what is happening, in the memoirs published by the correspondents, one can see the disappointment and resentment felt for Italy in Germany. In particular, the paper focuses on the memoirs written by Mario Mariani and Amedeo Morandotti, both correspondents from Germany.
c
Keywords: Journalism; Identity; Stereotypes; Italy; Germany
1 Introduzione
Il presente contributo analizza la narrazione dell’altro e la rappresentazione del nemico presenti nelle memorie redatte dai corrispondenti italiani nel Kaiserreich tedesco nel periodo che precede la partecipazione dell’Italia al primo conflitto mondiale nel 1915. In particolare, questa analisi prenderà in esame due casi di studio: gli ego-documenti redatti da Mario Mariani e Amedeo Morandotti.
Nell’arco temporale preso in esame, i corrispondenti giocano un ruolo importante nell’influenzare e condizionare l’opinione pubblica, descrivendo una realtà altra (in questo caso, quella tedesca) che potrebbe rappresentare per l’Italia una minaccia da temere oppure un ostacolo al completamento dell’unificazione del Regno.
Già nel 1878 è possibile individuare uno dei primi corrispondenti italiani in Germania per un grande quotidiano quale la Gazzetta Piemontese (futura La Stampa): si tratta dello scrittore e giornalista Ferdinando Fontana che riporterà le diverse esperienze vissute a Berlino e in altri centri tedeschi nelle memorie In Tedescheria. Quadri d’un viaggio in Germania (Fontana 2005). A Fontana seguono poi altri corrispondenti che sperimentano in prima persona (e successivamente raccontano negli articoli e nelle memorie) il progresso tecnologico e scientifico del Kaiserreich tedesco, rimanendone sorpresi e al contempo diffidenti: parliamo, ad esempio, di Umberto Coccoluto Ferrigni (in arte Yorickson) per il Corriere della Sera (1893-1903) e di Giuseppe Antonio Borgese per La Stampa (1906-1908) (Borgese 1917).
È interessante osservare la presenza di corrispondenti italiani in Germania tra il 1914 e il 1915, ovvero tra lo scoppio della Prima guerra mondiale e la partecipazione dell’Italia al conflitto accanto all’Intesa. Non si tratta di corrispondenti di guerra, bensì di giornalisti che rimasero in Germania – fin quando possibile – non soltanto per seguire gli sviluppi militari tedeschi, ma anche per dare testimonianza di un mutamento di Stimmung nei confronti dell’Italia (Licata 1972). Mario Mariani e Amedeo Morandotti (rispettivamente per Il Secolo e il Corriere della Sera), oltre agli articoli, scrissero memorie e diari che oggi rappresentano importanti fonti per comprendere lo sviluppo dell’immagine dell’altro/nemico dalla dichiarazione di neutralità del Regno fino al ‘tradimento’ del 1915.
Sebbene soggetta a una severa censura, nel periodo tra lo scoppio della Grande Guerra nel luglio 1914 e l’ingresso dell’Italia nel conflitto nel maggio 1915, la stampa ha svolto un ruolo fondamentale nel condizionare e riflettere le diverse posizioni dell’opinione pubblica nazionale fra interventismo e neutralismo. I giornali interventisti, tra i quali alcuni grandi organi liberali e democratici come la Gazzetta del Popolo, il Corriere della Sera, Il Secolo, Il Resto del Carlino, Il Giornale d’Italia, Il Messaggero, videro aumentare considerevolmente il numero delle copie vendute, mentre quei quotidiani che rimasero a presidiare il fronte dell’opposizione al conflitto – La Stampa e La Tribuna – subirono un drastico calo delle vendite (Forno 2012).
2 Le memorie dalla Germania: La Germania nelle sue condizioni militari ed economiche dopo nove mesi di guerra di Mario Mariani
Mario Mariani, scrittore, poeta, traduttore e giornalista, dall’agosto 1914 al giugno 1915 scrisse articoli e memorie che forniscono una visione nitida del cambiamento di atteggiamento della Germania nei confronti dell’Italia. Ancora molto giovane (era nato nel 1883), nel 1907 Mariani lasciò Solarolo, dove il padre, possidente terriero, aveva preparato per il figlio un posto nell’azienda di famiglia, per trasferirsi a Berlino (Falco 1980). Dalla capitale del Kaiserreich tedesco Mariani scrisse articoli per Il Messaggero e per Il Secolo dal 1909 fino al 1915, quando decise di partecipare al primo conflitto mondiale come inviato di guerra tra gli alpini.
Oltre agli articoli, Mariani stese le sue memorie La Germania nelle sue condizioni militari ed economiche dopo nove mesi di guerra. Dalla lettura e dall’analisi di questi ego-documenti, che Mariani sin dal suo concepimento destinò alla pubblicazione, si nota la sofferenza patita dal corrispondente in seguito al cambiamento di atteggiamento in Germania nei confronti dell’Italia e soprattutto degli italiani residenti nel Kaiserreich. Nelle sue memorie Mariani afferma:
dallo scoppio della guerra io ho avuto la disgrazia di viver sempre fuori d’Italia e quasi sempre in Germania. […] All’estero si dice – non lo si stampa per ragioni di sicurezza – si dice: “gli italiani saran più o meno traditori, ma mezzo tra vigliacchi e buffoni lo son di certo.” […] Gli italiani che vivono all’estero – e il peggio si è che molti dovran viverci anche dopo la guerra – ne sanno qualcosa e sanno anche quel che consegue da premesse del genere. Un uomo subisce sempre l’influenza de’ circoli che frequenta, del paese in cui si trova, e per dare una idea pallida dello stato d’abiezione morale nel quale vivono gli italiani all’estero da parecchi mesi, confesserò che io, sebbene non sia di cute eccessivamente delicata, a Berlino avevo preso l’abitudine di sputarmi in faccia tre volte, allo specchio, ogni mattina, per prepararmi con quell’auto-insulto a subire con francescana rassegnazione tutte le ironie e i vituperi degli altri durante la giornata. (Mariani 1915: 148-151)
Queste parole confermano la sensazione che emerge sin dalle prime pagine delle memorie di Mario Mariani: la diffidenza dei tedeschi nei confronti degli italiani dalla dichiarazione di neutralità. A questa sfiducia si aggiunge, poi, il sospetto nei confronti dei giornalisti stranieri, di cui è vittima anche Mario Mariani, con visite che la polizia fa a casa del corrispondente.
Tuttavia, non si può affermare che il giornalista de Il Secolo abbia nutrito nei confronti della Germania esclusivamente sdegno e rabbia. Talvolta nelle sue memorie sembrano prendere piede un certo rammarico e un po’ di amarezza per una nazione che l’ha ospitato a lungo e che, secondo Mariani, ha commesso il grande e imperdonabile errore di ritenersi una potenza imbattibile in Europa e nel mondo: «ormai tutto che è germanico abbisogna del prefisso super. Il professore Von Eucken […] ha ora aggiunto al superuomo di Nietzsche il superstato. Il superstato naturalmente sarebbe la Germania» (Ivi: 30).[1] A questa particolare presunzione, inoltre, Mariani associa un deciso analfabetismo affettivo: «si tratta di gente che, un po’ per naturale apatia un po’ in seguito a speciali sistemi pedagogici, ha ridotto affetti e sentimenti a quel minimo che è necessario per lasciare i vocaboli nel dizionario» (Ivi: 132). Ciò sembrerebbe caratterizzare tutti i tedeschi e avrebbe contribuito alla fin troppo impetuosa partecipazione al conflitto:
sembran cinici, quando si pensi che non fanno un grande sforzo per andare alla morte senza voltarsi addietro dappoi che addietro, data la loro atonia affettiva, non lasciano un bel nulla; sembran stoici invece quando si voglia credere alla loro affermazione di trascendentalismo patriottico: bisogna superare e scordare ogni nostro affetto o interesse e tutto sacrificare quando il pericolo incombe sulla patria. (Ibidem)
Secondo Mariani, l’esaltazione dei tedeschi per la guerra, «creat[a] da una stampa disciplinata e ottimamente diretta» (Ivi: 2), non trova sfogo esclusivamente nell’adesione di milioni di uomini – soldati e volontari – pronti a partire per il fronte; infatti, questo entusiasmo sfocia nell’odio e nel disprezzo del nemico, anche se non ancora dichiarato. Si riprende, dunque, il discorso affrontato poco prima: nel giro di pochi giorni dall’inizio della Grande Guerra, l’italiano alleato si trasforma in un pericoloso altro da minacciare ed eventualmente da annientare:
ci riconoscono sempre dovunque, e ci trattan da traditori e da buffoni. Ogni loro parola è uno scracchio [sic], uno schiaffo, ogni loro frase un sarcasmo tagliente, rovente, caustico. Ce n’è che mentono, per diplomazia, ma sotto il miele della indifferenza, giù nella strozza, l’odio raschia: Come ci odiano!… Perché sostengono che li abbiamo traditi ancora una volta, come nel ‘66, e perché sembrava giustissimo a loro che noi si dovesse aiutar l’Austria a schiacciare la Serbia e aiutar loro ad annettersi il Belgio e il resto. (Ivi: 49-50)
Con l’entrata in guerra dell’Italia accanto all’Intesa, di nuovo in Italia Mariani non può fare a meno di ricordare gli ultimi mesi vissuti nella solitudine e nella paura. Ciò nonostante, nelle sue memorie non mancano episodi in cui il giornalista ripercorre i tentativi – seppure precari – di rivincita su tutti quei tedeschi che denigrano e offendono l’alleata ‘traditrice’. Incontrando per caso in treno un sottotenente imperiale tedesco che lo crede un francese, il corrispondente discute con quest’ultimo dell’andamento del conflitto:
– se fossi francese non sarei qui; sono italiano. Ebbe un sorriso un po’ tagliente. – Siamo alleati, dunque, ma non pare che abbiate troppa voglia di battervi, voialtri. Ironizzando una versione che i suggeritori della Wilhelmstrasse andavan divulgando fra il popolo, risposi: Sa, son cose che non si fanno mai di buona voglia per gli altri, ma del resto il Kaiser non lo ritiene ancora necessario. Quando ci darà l’ordine…. [sic] – Uhm!… Non importa: ce la faremo anche da soli. Ma io non ho potuto leggere giornali per un pezzetto. Cosa si pensa in Italia? – Che avete torto e che perderete. – Due cose falsissime, specialmente la seconda. – Può darsi. Ma è un’opinione un po’ diffusa fuor di Germania sopratutto dopo le giornate della Marna. (Ivi: 64-65)
3 Le memorie dalla Germania: Germania in guerra. Diario berlinese di Amedeo Morandotti
Amedeo Morandotti è corrispondente dalla Germania per il Corriere della Sera dal 1910 (lavora, sempre come giornalista tra il Kaiserreich tedesco e l’Austria, anche per Il Secolo). A differenza di Mario Mariani, che è stato anche un noto scrittore, sono poche le informazioni che si hanno sulla vita di questo corrispondente. Inviato dal suo giornale allo scoppio del primo conflitto mondiale a compiere un reportage dalle aree belliche, ciò che ne deriva è la raccolta Germania in guerra. Diario berlinese (agosto 1914-aprile 1915), in cui esamina le condizioni dell’Impero tedesco e di quello austro-ungarico nei primi mesi del conflitto fino all’entrata in guerra dell’Italia.
Prima dell’analisi degli ego-documenti di Morandotti, è importante sottolineare come il suo atteggiamento e quello di Mariani nei confronti della Germania siano diversi: se l’inviato de Il Secolo fa trasparire nelle sue memorie l’astio e il disprezzo per il Kaiserreich, il corrispondente del Corriere della Sera mantiene quasi sempre un lucido distacco e una certa obiettività.
Tuttavia, è anche vero che in alcuni passaggi tratti dalle memorie di Morandotti, in cui il corrispondente utilizza termini negativi, risulta chiara la posizione antitedesca del giornalista. Ad esempio, descrivendo ai suoi lettori il Kaiserreich, l’inviato afferma che si tratta di «un paese in cui si praticava la coltura intensiva della coscienza di classe e di sottoclasse e in cui fiorivano rigogliosissimi il senso di casta e l’odio di razza» (Morandotti 1915: 30).[2] E riguardo la partecipazione alla guerra e la grande preparazione militare scrive:
la Germania è oggi un paese diviso in venticinque zone militari: tutto il resto è scomparso. Di colpo, il 31 luglio, come sotto la pressione di un bottone elettrico il poderoso macchinario tedesco ha scattato con funzionamento perfetto mutando dischi. Le autorità civili si trassero da parte e il potere esecutivo passò ai venticinque generali comandanti di armata. Ciò fatto l’Impero sbarrò i suoi confini espellendone gli elementi estranei. Paese preparato per la guerra. (Ivi: 17)
Come già sottolineato poco sopra, a differenza di Mariani, Morandotti non si lascia andare a dichiarazioni sdegnate tout court. Infatti, ai suoi lettori il giornalista cerca innanzitutto di spiegare le ragioni che potrebbero aver portato alla partecipazione entusiasta dei tedeschi al conflitto. Se molti contemporanei incolpano il «bisogno di espansione» (Ivi: 75) della Germania, per Morandotti, in realtà, queste «tendenze imperialiste penetrarono a fatica nel popolo. Ancora oggi potete sentirvi dire: Noi vogliamo conquistare? noi vogliamo dominare? noi vogliamo semplicemente che ci lascino vivere» (Ibidem). Dunque, secondo il giornalista, la guerra non dipenderebbe dalle mire espansionistiche dei tedeschi, bensì da questioni politiche che avrebbero poco a che fare con le reali esigenze della popolazione: «ma la guerra per dirla con una molto citata sentenza di Clausewitz è semplicemente la continuazione della politica con altri mezzi» (Ivi: 77).
Sicuramente, ciò che emerge dalla raccolta di Morandotti è il senso di scarsa fiducia dei tedeschi nei confronti degli italiani. In Germania si osserva con sospetto la dichiarazione di neutralità del Regno e chiunque riconosca Morandotti come italiano non esita a minacciarlo della furia tedesca, se l’alleato continuerà con il suo neutralismo oppure, ancora peggio, deciderà di entrare in guerra contro la Germania: «io stesso son presto scoperto straniero e la scoperta desta più curiosità che sospetto. Straniero come? Italiano? Dann sind Sie mit uns! Allora è con noi – O quasi – corregge un terzo a mezza voce» (Ivi: 28).[3]
È interessante osservare come Morandotti riporti nelle sue memorie il continuo mutare dell’atteggiamento tedesco verso l’Italia: difatti, in alcuni passaggi, si può notare un’oscillazione tra la delusione per la neutralità e le minacce di vendetta. Nel primo caso, il senso di tradimento e lo sconforto per il ‘voltafaccia’ del Regno si manifestano in tutti quei tedeschi amanti dell’immagine stereotipata e standardizzata dell’Italia ‘da Grand Tour’:
e trovate infine fuori della politica il tedesco dalla tradizione goethiana, quello che cala ogni anno in Italia, ama tradizionalmente i monumenti, le canzoni, le osterie, si rifugia in quest’aria a riposare, a rinfrescarsi. Questo tipo ancora rintracciabile si addolora di quel che sta avvenendo come di un tradimento personale. Dove andrà? Un legame antico si spezza. Weggeworfene Liebe. Amore buttato via. (Ivi: 172)[4]
Se una parte dei tedeschi, dunque, prova soprattutto amarezza per la mancata partecipazione dell’Italia al conflitto accanto agli alleati, una buona porzione della popolazione, come si è anticipato, sentendosi tradita da un ‘affronto’ simile, non esita a rivolgere minacce e intimidazioni agli italiani rimasti in Germania, compreso il giornalista:
una volta un gentile amico mi minacciò: Se ci venite contro, state sicuri che prima o poi scendiamo e vi veniamo a züchtigen (castigare). – Un momento – diss’io –; nel peggiore dei casi ci verrete a battere: züchtigen è proprio del maestro o del padrone. Il tedesco si scusò sinceramente; come al solito non aveva avuto male intenzioni; e acconsentì poi ironico e cordiale: – Diciamo schlagen, per carità, diciamo battere. (Ivi: 171)[5]
Infine, tra questi diversi comportamenti si possono annoverare, seppur più raramente, i tentativi tedeschi di convincere gli italiani ad aderire al conflitto attraverso promesse di ricompense e premi:
noi vogliamo che diventiate la prima potenza latina. Il posto della Francia. Ma lasciate stare l’Adriatico. Quello è, come dire?, la vostra schiena. L’Italia guarda a ponente. Tunisi ve l’ho già dato; eccovi la Corsica, Nizza, la Savoia. Non vi inebbria questa idea? Ma v’è pure una gioventù nazionalista in Italia, vi è pure un imperialismo italiano che ha ragione di essere come il nostro; noi, voi, nazioni ascendenti. Che direste di Marsiglia? Se resisto ancora un po’ mi offre la Guascogna. (Ivi: 33)
In circa dieci mesi i rapporti italo-tedeschi, tanto complessi e delicati, subiscono un improvviso mutamento, a cui forse non si è mai assistito prima in un lasso di tempo così ristretto. La cooperazione intellettuale, culturale, scientifica, tecnologica e politica nata fra i due Paesi affronta un momento di stasi e di regressione segnata violentemente dalla cesura del primo conflitto mondiale. Il lavoro dei corrispondenti di questo periodo è fondamentale perché influenza l’opinione pubblica attraverso determinate immagini dell’altro.
L’analisi degli ego-documenti selezionati ha cercato di sottolineare come la diversa rappresentazione del tedesco e dell’italiano fornita dai corrispondenti in Germania abbia avuto due principali obiettivi: da una parte presentare il Kaiserreich, protagonista assoluto del conflitto, particolarmente crudele nei confronti di chi è straniero, soprattutto i ‘traditori’; dall’altra sottolineare lo spirito di sacrificio e la tolleranza degli italiani in Germania, vessati e attaccati da una buona fetta della popolazione tedesca. Infine, se in Morandotti i tedeschi assumono nei confronti dell’Italia atteggiamenti diversi (delusione e sdegno), in Mariani è subito evidente il nuovo ruolo degli ‘antichi’ alleati: quest’ultimi, difatti, sono diventati i nemici da cui guardarsi e da distruggere in guerra.
Bibliografia
Borgese, Giuseppe Antonio (1917). La nuova Germania. La Germania prima della guerra, Milano, Treves.
Falco, Emilio (1980). Mario Mariani tra letteratura e politica, Roma, Bonacci.
Fontana, Ferdinando (2005). In Tedescheria. Quadri d’un viaggio in Germania, Milano, Lampi di stampa.
Forno, Mauro (2012). Informazione e potere. Storia del giornalismo italiano, Bari, Laterza.
Licata, Glauco (1972). Storia e linguaggio dei corrispondenti di guerra. Dall’epoca napoleonica al Vietnam, Milano, Guido Miano.
Mariani, Mario (1915). La Germania nelle sue condizioni militari ed economiche dopo nove mesi di guerra. Lettere, Milano, Treves.
Morandotti, Amedeo (1915). Germania in guerra. Diario berlinese (agosto 1914-aprile 1915), Milano, Ravà.