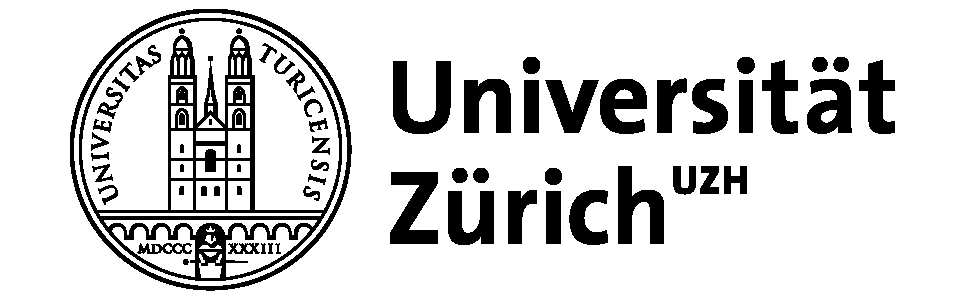La cintura di Fierapace. Riscritture mariane e identità toscana nel Fierabraccia
Amy De Gottardi
Universität Zürich / École Pratique des Hautes Études-PSL
Abstract: In Fierabraccia, a rewriting of the chanson de geste of Fierabras, an object that in the source text was a fairy artefact is presented as the girdle that once belonged to the Virgin Mary. This study shows that this modification is linked to the memory of the cult of the relic of the Holy Girdle in the Tuscan city of Prato. This hypothesis is supported, firstly, by the analysis of the varia lectio: two redactions preserve a reference to Prato, while the others present trivializations. Secondly, it is supported by the importance given to the miraculous girdle in Fierabraccia. In this way, the poet would have deliberately introduced references to the peculiar local cult into the story that had reached him from beyond the Alps, thus bringing his model closer to the cultural background of his new audience.
c
Keywords: Fierabraccia; Fierabras; Holy Girdle; Medieval literature; Intertextuality
1 Dal Fierabras al Fierabraccia
Il Fierabras è una chanson de geste composta nell’ultimo terzo del XII secolo che narra, in una serie di peripezie guerresche e romanzesche, della conversione del saraceno Fierabras e del suo intervento al fianco dei paladini di Carlo Magno per il recupero delle reliquie della Passione.[1] Stando al numero elevato di manoscritti che ci sono pervenuti e ai numerosi rifacimenti e traduzioni di cui essa fu oggetto,[2] la chanson dovette godere di un grande successo nel tardo Medioevo. Per quanto concerne l’area italiana, è possibile che la leggenda circolasse già nella prima metà del Trecento (Formisano 2003: 202-203), ma la sua diffusione venne assicurata soprattutto da un anonimo cantare in ottave, il Fierabraccia, la cui composizione è da far risalire con tutta probabilità alla seconda metà del secolo.[3]
Il rifacimento della chanson di Fierabras nella Penisola italiana determina, insieme al cambio di codice linguistico, qualche modifica significativa a livello di contenuto. Malgrado la chanson risulti generalmente abbreviata – nelle descrizioni di persone, oggetti, ma anche di intere scene – nel Fierabraccia vi sono anche episodi che vengono sviluppati e ampliati in modo del tutto autonomo rispetto al modello. Mi soffermerò qui di seguito sulla traiettoria di un oggetto specifico, la cintura della protagonista femminile Fierapace, per illustrare come il processo di ricezione e assimilazione del testo originario abbia dato luogo a delle innovazioni strettamente legate all’identità culturale locale.
Nel Fierabras le reliquie della Passione, sottratte dal pagano Fierabras poi convertitosi al cristianesimo, sono il vero e proprio motore della narrazione, in quanto gli sforzi dei protagonisti risultano interamente mirati a restituirle alla Cristianità. Il poeta comincia la sua chanson proprio stabilendo un legame tra la sua storia e il contesto della fiera del Lendit a Saint-Denis, luogo dove furono portati gli oggetti sacri riconquistati da Carlo Magno.[4] Le reliquie da lui menzionate sono la corona di spine («la corronne, dont Dex fu corronnez»; Fierabras, v. 9), i chiodi della Passione («les seintismes cloz», v. 10) e il lenzuolo funebre di Gesù («le signe honorez», v. 10), mentre attraverso un generico «autres reliques dont ill i out assez» (v. 11) segnala che questa rassegna non è esaustiva. Poco più avanti (vv. 64-65) indica un’ulteriore reliquia rubata da Fierabras a Roma, ossia la croce utilizzata per crocifiggervi Cristo.[5]
Nel cantare il tema del recupero delle reliquie rimane fondamentale. Già nell’ottava iniziale del Fierabraccia se ne trova un primo elenco:
Altissimo Idio padre e signore,
vo’ cominciar un bel dir dilectoso.
Di Carlo Mano vi vo’ dire il vigore
– se m’ascoltate, o’ gente, con riposo –
come acquistò con sua forza e valore
le reliquie che furon di Dio glorioso:
cioè il sudario, e chiovi e la corona
e la cinctura della madre anchora. (Fierabraccia, I, 1)[6]
Le prime tre reliquie, legate all’episodio evangelico della crocifissione di Cristo, corrispondono a quelle del Fierabras: il sudario, i chiodi e la corona di spine. Quanto alla «cinctura della madre» (v. 8) menzionata per ultimo, si tratta invece di un oggetto tradizionalmente legato all’Assunzione, ovvero il momento in cui Maria, al termine della sua vita terrena, l’avrebbe consegnata a San Tommaso. Il Fierabraccia aggiunge quindi all’inventario delle reliquie della tradizione francese un elemento inedito, la cintura della Vergine.
In realtà, una cintura prodigiosa appare già nel Fierabras, benché qui non venga presentata come una delle reliquie rubate dai saraceni. Essa è infatti un tipico oggetto fatato di origine presumibilmente pagana, custodita dalla saracena Floripas come parte del suo vestiario abituale, e possiede la virtù miracolosa di preservare dai morsi della fame,[7] la stessa che verrà attribuita, nel cantare, alla cintura della Vergine. Nella trasposizione della chanson de geste in area italiana si produce quindi un’innovazione essenziale: un oggetto magico di tipo fiabesco, associato a un personaggio saraceno, assume lo statuto di una vera e propria reliquia mariana. Inoltre, mentre la cintura fatata di Floripas ha scarso rilievo all’interno della chanson, nel Fierabraccia la cintura della Vergine spicca tra tutte le altre reliquie in quanto riveste un ruolo di primo piano nello sviluppo della narrazione.
2 La cintura della Vergine «che a Prato sta»
L’assimilazione dell’accessorio magico di Floripas alla cintura della Vergine si può comprendere dando uno sguardo al culto della Sacra Cintola come realtà storica. In particolare, tra le varie reliquie dell’Europa occidentale di cui si ha notizia (Boussel 1971: 184-185), la narrazione del Fierabraccia si collega in maniera più pertinente, in virtù della sua collocazione geografica, alla leggenda del Sacro Cingolo conservato tutt’oggi nel Duomo di Prato. Stando agli studi di Franco Cardini (2014) le prime notizie della presenza della cintura della Vergine a Prato risalirebbero agli anni 1276-1278, ma secondo la leggenda medievale la reliquia sarebbe giunta da Gerusalemme nella città toscana già nel corso del secolo precedente.[8] La maggioranza delle fonti letterarie che narrano della reliquia pratese sono collocabili tra il XIII e il XIV secolo, dunque in un periodo precedente o coevo a quello della presunta composizione del Fierabraccia.
Un riferimento esplicito al culto pratese del Sacro Cingolo, benché in passato non sia sempre stato riconosciuto come tale, è peraltro leggibile in due dei manoscritti che tramandano il Fierabraccia. Esso si trova in corrispondenza della scena in cui Fierapace presenta il suo prezioso forziere ai cavalieri cristiani che sono con lei nella fortezza di Agrimoro, posta sotto assedio (Fierabraccia IX). Da questo forziere la fanciulla estrae una ad una le reliquie affidatele dal fratello Fierabraccia:
E Poi gli mostro echiodi ella chorona
El sudario lalancia ella cintura
Cheffu chome nella storia neragiona
Della medre didio uergine pura
Eaprato sta chelsa ogni persona[9]
Questa ottava aveva richiamato l’attenzione già di Albino Zenatti nella sua recensione ottocentesca alla prima edizione del Fierabraccia. Nel testo del manoscritto Riccardiano 1144 (Toscana, seconda metà del XV secolo), riportato sopra, Zenatti aveva infatti riconosciuto un’allusione alla cintura venerata a Prato,[10] interpretandola come probabile indizio dell’origine dell’autore del cantare (Zenatti 1880: 116). Un passaggio corrispondente si trova anche nel manoscritto conservato a Volterra edito da Melli (1984; VI, 34, 1-5):[11]
Poi li monstrò li chiodi e la corona
e ’l sendado, la lancia e la centura
che fo, sì come l’istoria ragiona,
de la Madre de Dio vergene pura,
che a pPrato sta che ’l sa omne persona.
Tuttavia, dalla stessa ottava Melli trae considerazioni ben diverse: associando la relativa «che a pPrato sta che ’l sa omne persona» alla «Madre de Dio» del verso precedente, vi scorge infatti un riferimento alla chiesa di Santa Maria delle Carceri di Prato (1984: 20-21). Lo studioso utilizza poi questa lettura per fissare un terminus post quem per la datazione della redazione trasmessa dal manoscritto, che secondo lui doveva quindi risalire a un periodo successivo alla costruzione della chiesa, effettuata tra il 1485 e il 1493. Rispetto a quella di Zenatti, che riferisce la presenza a Prato alla «centura» della Vergine menzionata qualche verso più in alto, questa interpretazione mi pare meno convincente. Infatti, mentre le chiese dedicate a Maria sono diffuse capillarmente sul territorio, quello del Sacro Cingolo conservato nel Duomo è un culto peculiare, per l’appunto, proprio della città di Prato. Di fronte a un riferimento chiaro e univoco come quello alla reliquia pratese, non sarebbe quindi economico ravvisarne uno più generico. Di conseguenza, ritengo opportuno correggere la lettura fornita da Melli di questa ottava, secondo il testo trasmesso dai manoscritti Riccardiano e Volterrano, a favore di quella di Zenatti.[12]
Bisogna tuttavia rilevare che questi due manoscritti sono gli unici testimoni del Fierabraccia a conservare tale riferimento alla città di Prato. L’incunabolo ora conservato alla Biblioteca Corsiniana e stampato a Firenze verso il 1487-1489 presenta una soluzione “intermedia”, dove al v. 5 dell’ottava corrispondente si legge «aperto sta che iluede ogni persona»[13]. «aperto», con valore avverbiale (‘chiaramente’, ‘apertamente’), è un possibile errore di lettura per «a Prato». Nel manoscritto “Giovio” (XV secolo), di origine presumibilmente lombarda (Rosiello 1987: 67), l’intero primo emistichio, dove nel Riccardiano e nel Volterrano si trova il riferimento a Prato, viene formulato diversamente, e il verso che ne scaturisce è «e sì la vite onïa persona» (Melli 1996; VI, 34, 5). Infine, quattordici esemplari a stampa dell’Innamoramento di Rinaldo da Montalbano, di edizioni apparse tra gli ultimi anni del Quattrocento e la metà del Seicento circa presso vari stampatori veneziani, presentano un’amplificazione del tutto corrispondente al Fierabraccia. Questa redazione del Fierabraccia, nella stampa del 1547 che prendo in esame, presenta un’estesa rielaborazione che tocca l’intera ottava, a tal punto che persino la lezione «cintura» viene sostituta da un’incongrua «figura», eliminando qualsiasi riferimento alla reliquia.[14]
Le varianti riscontrate in queste redazioni del Fierabraccia possono tutte spiegarsi efficacemente tramite un criterio fondamentale della critica testuale, quello della lectio difficilior/facilior, che stabilisce che «di norma, in presenza di varianti alternative più e meno “difficili”, quella più complessa e caratterizzata da una sua particolare difficoltà o rarità, riguardo alla forma o al senso, è quella che ha maggiori probabilità di essere la lezione autentica» (Malato 2008: 73). Supponendo che i manoscritti Riccardiano e Volterrano – entrambi antichi[15] e attestanti la diffusione del Fierabraccia in territorio toscano, luogo di fioritura della letteratura canterina – presentino la lezione autentica, le altre redazioni, cronologicamente e/o geograficamente più distanti, avrebbero quindi perso il riferimento al Sacro Cingolo, complice forse un disinteresse o una mancata conoscenza del culto pratese nei luoghi di rielaborazione del cantare.
3 Da oggetto sacro a oggetto letterario
Benché degli indizi testuali, come si è mostrato, siano presenti solo in parte della tradizione, l’ipotesi di un’assimilazione della cintura del Fierabras alla famosa reliquia mariana di Prato è supportata anche da riflessioni di natura letteraria.[16] Il nuovo orientamento della sfera di appartenenza della cintura, che da oggetto magico pagano diventa una reliquia mariana dalle virtù soprannaturali accertate, è da riallacciare infatti ad alcune modifiche nella trama narrativa del Fierabraccia rispetto al suo modello. Queste riguardano in particolare l’aggiunta e lo sviluppo di alcuni episodi che vedono protagonista proprio la cintura della Vergine. Penso, per esempio, all’ampliamento dell’episodio del tentato furto da parte di un negromante saraceno (Fierabraccia IX-X) che, grazie alle sue nuove tonalità comiche, diventa uno dei più godibili del cantare. Oppure, alla consacrazione di alcune ottave all’inedita narrazione di come la cintura, irrimediabilmente smarrita nel Fierabras, torni infine prodigiosamente nelle mani dei paladini (Fierabraccia XII). Inoltre, nel Fierabraccia sarà proprio la virtù miracolosa dello stesso oggetto a permettere la sopravvivenza dei paladini di Carlo Magno assediati dai saraceni nella fortezza di Agrimoro (Fierabraccia IX). Tali modifiche sono spie di una volontà di riallacciarsi al culto pratese non solo attraverso un semplice riferimento al Sacro Cingolo – come potrebbe esserlo quello visto al §2 –, ma anche accentuando la preminenza della reliquia mariana all’interno del cantare. Questo nuovo rilievo viene mantenuto in tutte le redazioni del Fierabraccia, anche in quelle che non presentano il riferimento esplicito al Sacro Cingolo di Prato.
In conclusione, il Fierabraccia può aver subito l’influsso del culto della reliquia del Sacro Cingolo di Prato nella misura in cui un poeta a conoscenza del culto locale, traducendo e riscrivendo la storia di Fierabras, avrebbe riorganizzato la materia già disponibile inserendovi dei riferimenti alla reliquia pratese. Il Fierabras forniva lo spunto iniziale: una cintura meravigliosa, dal grande potenziale suggestivo, ma pur sempre un oggetto pagano dal potere oscuro. Un poeta italiano avrebbe così introdotto nella storia giuntagli d’Oltralpe degli accenni al culto locale, trasformando l’oggetto in una preziosa reliquia mariana. Questo non implica necessariamente, a mio avviso, che la patria dell’autore stesso fosse la città di Prato, come aveva suggerito Zenatti (1880: 116), dato che la notizia di questa tradizione doveva essere ben diffusa anche al di fuori della città toscana. Ma di certo, affinché la modifica fosse pienamente apprezzata, il nuovo pubblico doveva essere per lo meno a conoscenza del peculiare culto pratese. Naturalmente, la narrazione del Fierabraccia non poteva in nessun modo sostituirsi alla leggenda ufficiale, che a quell’altezza cronologica possedeva già una cospicua documentazione letteraria. Ma l’integrazione della cintura della Vergine nell’intreccio del Fierabras oitanico risulta essere un omaggio tutto fantasioso a questo oggetto sacro, che doveva verosimilmente avvicinare la chanson de geste francese al retroterra culturale e ai gusti del suo nuovo pubblico.
Bibliografia
Balletti, A. (ed.) (1891). [Frammenti di una redazione del «Cantare di Fierabraccia»]. Per le nozze Livaditi Arnaboldi, Reggio Emilia, Tip. Calderini.
Bensi, Giovanni (2017). La cintura della Madonna, Prato, Società Pratese di Storia Patria.
Boussel, Patrice (1971). Des reliques et de leur bon usage, Paris, Balland.
Cardini, Franco (2014). «Identità cittadina, mariodulìa e culto delle reliquie. Il “caso” pratese», in: Maffei, Paola & Gian Maria Varanini (eds.), “Honos alit artes”. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri. Vol. II, Gli universi particolari, Firenze, Firenze University Press, 177-185.
Formisano, Luciano (2003). «Les “Cantari di Fierabraccia e Ulivieri”», in: Le Person, Marc (ed.), Le rayonnement de «Fierabras» dans la littérature européenne. Actes du colloque international, 6 et 7 décembre 2002, Lyon, CEDIC, 2003, 201-212.
Heyse, Paul (ed.) (1856). Romanische Inedita auf italiänischen Bibliotheken, Berlin, Hertz.
Le Person, Marc (ed.) (2003a). Fierabras, chanson de geste du XIIe siècle, Paris, Champion (Les classiques français du Moyen Âge, 142).
Le Person, Marc (2003b). «Présentation thématique du Rayonnement de “Fierabras” dans la littérature européenne», in: Le Person, Marc (ed.), Le rayonnement de «Fierabras» dans la littérature européenne. Actes du colloque international, 6 et 7 décembre 2002, Lyon, CEDIC, 9-44.
Le Person, Marc (ed.) (2012). Fierabras, chanson de geste du XIIe siècle. Traduction, présentation, bibliographie et notes par M. Le Person, Paris, Champion (Traductions des classiques français du Moyen Âge, 91).
Malato, Enrico (2008). Lessico filologico. Un approccio alla filologia, Roma, Salerno.
Melli, Elio (ed.) (1973). I Cantari di Rinaldo da Monte Albano, edizione critica con introduzione e glossario, Bologna, Commissione per i testi di lingua.
Melli, Elio (1978-1979). «La redazione dei “Cantari di Fierabraccia e Ulivieri” contenuta nell’“Innamoramento di Rinaldo da Monte Albano”», Atti dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna. Classe di scienze morali, Rendiconti 67, 75-96.
Melli, Elio (ed.) (1984). I cantari di Fiorabraccia e Ulivieri, testo mediano inedito, Bologna, Patron (“Biblioteca di Filologia romanza della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna”, 3).
Melli, Elio (1987). «L’édition critique de “I cantari di Fierabraccia e Ulivieri”», Au carrefour des routes d’Europe: la chanson de geste. Tome II. Xe congrès international de la Société Rencesvals pour l’étude des épopées romanes, Strasbourg, 1985, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, II, 1247-1251.
Melli, Elio (ed.) (1996). Il «Fierabraccia» comense fra preziosità umanistiche e antico dialetto lombardo, Bologna, Patron, (“Biblioteca di Filologia romanza della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna”, 10).
Rosiello, Giovanna Barbara (1987). «Per la classificazione della “Spagna” in rima contenuta nel manoscritto della Società Storica Comense», Quaderni di Filologia romanza della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna 6, 63-80.
Stengel, Edmund (ed.) (1881). «El cantare di Fierabraccia e Uliuieri», italienische Bearbeitung der Chanson de Geste «Fierabras», Marburg, N. G. Elwert.
Strologo, Franca (2023). Il caso dell’«Orlando» laurenziano, Ravenna, Longo.
Zenatti, Albino (1880). «Rassegna bibliografica. Stengel E., Buhlmann C., “El cantare di Fierabraccia e Ulivieri”», Giornale di filologia romanza 3, 114-116.
* Questo contributo è derivato dalla mia tesi di Master («I Cantari di Fierabraccia e Ulivieri. Aspetti del soprannaturale nella tradizione italiana del Fierabras») condotta all’Università di Zurigo nell’anno accademico 2021-2022. Colgo l’occasione per ringraziare di cuore la professoressa Franca Strologo che, oltre ad avermi guidata allora nella redazione della tesi, mi ha offerto i suoi preziosi consigli ancora durante la stesura di questo articolo.
- L’edizione di riferimento per il Fierabras è stata curata da Marc Le Person (2003a), a cui dobbiamo anche una traduzione in francese moderno (Le Person 2012). ↵
- Per l’inventario e la descrizione dei testimoni rimando a Le Person (2003a: 22-56) e, per un panorama della circolazione del Fierabras nelle letterature europee, a Le Person (2003b). ↵
- In questo articolo mi riferisco al testo con il titolo abbreviato di Fierabraccia, ma la stessa opera è in genere conosciuta come Cantari di Fierabraccia e Ulivieri. Elio Melli ha curato le edizioni del testo secondo il manoscritto n. 6208 della Biblioteca Guarnacci di Volterra (Melli 1984) e il manoscritto “Giovio” in possesso della Società Storica Comense (fondo Aliati), quest’ultima corredata di uno studio introduttivo sull’insieme della tradizione del Fierabraccia (Melli 1996). L’edizione ottocentesca di Edmund Stengel (1881) si basa sull’incunabolo oggi conservato alla Biblioteca Corsiniana (Firenze, Jacopo di Carlo et Pietro de Bonaccorsi, verso 1487-1489), che da allora ha costituito la vulgata del Fierabraccia. Un’edizione parziale del manoscritto Riccardiano 1144 è stata pubblicata da Paul Heyse (1856) e una riproduzione fotografica dello stesso è oggi disponibile sul sito della Teca Digitale dei Manoscritti della Biblioteca Riccardiana (<http://teca.riccardiana.firenze.sbn.it/index.php/it/> [18.04.2024]). Il frammento conservato a Reggio Emilia (Miscellanea storico-letteraria, b. 1) è stato edito da Balletti (1891). Sulla rilevanza di questo frammento si veda il capitolo dedicato ai cantari carolingi e alle tracce di una circolazione trecentesca in Strologo (2023: 353-391). ↵
- È generalmente accettata l’ipotesi secondo la quale il Fierabras fu composto proprio in occasione di questa fiera, che si teneva annualmente a partire dall’inizio del XII secolo. La chanson rappresenterebbe così, come osserva Le Person (2003b: 11), «un prolongement culturel pour donner plus de résonance à la cérémonie du Lendit et surtout pour accréditer la présence de vraies reliques». ↵
- Di questa reliquia non rimane tuttavia traccia nel Fierabraccia. ↵
- L’edizione di riferimento è Stengel (1881), con alcuni piccoli accorgimenti che intendono facilitarne la lettura: l’introduzione di alcuni segni di punteggiatura, accenti e apostrofi, la distinzione tra u e v e la divisione delle parole secondo l’uso moderno. ↵
- «[Floripas] Cheint out un siglaton menuement ouvré ; / La bougle fu mout riche, de fin or esmeré. / Hom ne fame qui ll’ait n’avra le poil meslé, / Ne ja de venim n’iert ne d’erbe empoissonné ; / Et s’il avoit .III. jors ne quatre geünné, / S’esgardast la cheinture et la bougle doré, / Si avroit il le cors et le cuer saolé» (Fierabras, vv. 2120-2126). ↵
- Sul Sacro Cingolo si veda anche il volume di Bensi (2017). ↵
- Ms. Firenze, Biblioteca Riccardiana, 1144, 81r-v, che riporto in trascrizione diplomatica. ↵
- Nell’ultimo verso riportato, procedendo alla suddivisione delle parole, si legge infatti il riferimento toponomastico «a Prato sta». ↵
- Da un’analisi linguistica Melli (1984: 79) lo riconduce all’Italia mediana, formulando in particolare l’ipotesi di una «trascrizione in area centrale di un testo originariamente toscano». ↵
- Sebbene l’idea di Melli per cui i versi discussi sopra fossero da riferire alla chiesa di Santa Maria delle Carceri corroborasse la sua proposta di datazione del codice e della redazione che trasmette alla seconda metà del XV secolo, questa rimane valida in quanto basata anche e soprattutto sull’analisi paleografica e delle filigrane (vedi Melli 1984: 19-22). ↵
- La trascrizione diplomatica e il corsivo sono miei. ↵
- Su questa redazione del Fierabraccia, particolarmente corrotta, si veda lo studio di Melli (1978-1979). Per la descrizione completa delle stampe che la contengono, rimando invece a Melli (1973). Di queste stampe l’esemplare più antico e autorevole, secondo lo studioso, è conservato oggi al Trinity College di Dublino (El innamoramento de Rinaldo da Monte Albano, Venezia, Manfreo de Monfera da Strevo de Bonello, 1494). Poiché non mi è stato possibile visionare questo esemplare, le mie considerazioni si basano su una stampa più tardiva (Inamoramento de Rinaldo di Mont’Albano, Venetia, per Bartholomeo detto Imperatore, 1547) disponibile online: <https://play.google.com/store/books/details?id=eC08AAAAcAAJ&rdid=book-eC08AAAAcAAJ&rdot=1> [18.04.2024]. ↵
- Il testimone più antico – databile forse alla seconda metà del XIV secolo – è, come accennato sopra, quello di Reggio Emilia. Tuttavia, trattandosi di un frammento, esso tramanda solo un numero limitato di ottave, tutte collocate entro i primi due cantari, tra le quali non figura l’ottava in questione. In generale, il testo dell’ottava dato dal manoscritto Riccardiano, della seconda metà del XV secolo, rispetta fedelmente i dati della storia narrata, è logico e coerente a livello sintattico, e lo stesso si può dire del lessico. Ricordo inoltre che Melli (1987: 1249), in previsione di un’edizione critica del Fierabraccia, aveva designato come codice di base proprio questo manoscritto, in virtù dell’«ancienneté du texte et une certaine propriété et uniformité linguistique». ↵
- Devo purtroppo rimandare ad altra sede la discussione approfondita di questi aspetti. ↵